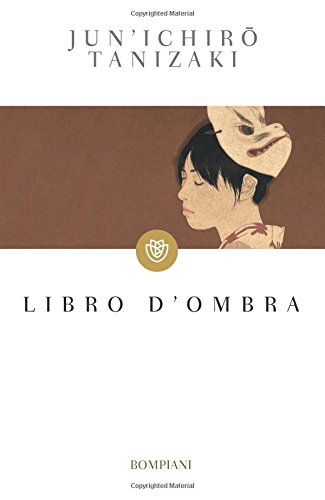Due sguardi sul Giappone, due epoche e due prospettive differenti: uno è il giornalista e scrittore italiano Goffredo Parise, l’altro lo scrittore giapponese Jun’ichiro Tanizaki.
1. L’eleganza è frigida
Goffredo Parise arriva in Giappone nel settembre 1980 su invito dell’ambasciatore Boris Biancheri, e qui si tratterrà per due mesi.
Indossando i panni di Marco, attraverso una narrazione in terza persona che gli permette un certo distacco, lo scrittore si fa acuto osservatore della cultura giapponese nelle sue molteplici espressioni, senza perdere di vista il costante termine di paragone con il Paese della Politica, quello “sconvolto per millenni da furti, ricatti e assassinii” che, manco a dirlo, è l’Italia.
La capacità di Parise sta nel cogliere, durante la sua breve permanenza, alcuni tratti essenziali di questo paese quasi indecifrabile; la narrazione procede per episodi frammentari, talvolta slegati gli uni dagli altri, ma che descrivono perfettamente l’esperienza dell’autore, fatta di sensazioni e percezioni, come quelle provate al cospetto del giardino zen nel tempio Ryōanji:
Deserto, color lilla e le piccole immense rocce muschiose appena rosate dal tramonto. Lì Marco cadde in contemplazione per un tempo ancora una volta ignoto, fino a quando il rosa si spense sulle rocce come sulle cime di Lavaredo. Allora giunse un’aria viola, portata come dal mantello di un fantasma, era ormai notte ed egli fu costretto dai guardiani ad uscire ma ormai era fatta: quel solo giorno felice valeva più di una intera vita e forse proprio questo era lo Zen.
Goffredo Parise, L’eleganza è frigida, Milano, Adelphi, 2008
Così, con un approccio curioso ma non freddamente analitico, poiché, come già accennato, lo scrittore si lascia trasportare più dalle sensazioni che non dall’analisi sistematica della realtà che lo circonda, visita oltre alla capitale le bellezze di Kyoto e Nara, assiste a incontri sportivi di sumō e tiro con l’arco, partecipa a spettacoli di teatro nō e musica gagaku, finendo per percepire una sorta di “illusione ottica“:
[..] l’aspetto della città, con i suoi edifici moderni e neutri, quali si sarebbero potuti trovare in qualunque città nel nord Europa o in America e i suoi abitanti tutti vestiti con abiti scuri, camicia e cravatta, illudeva Marco di trovarsi sempre nell’emisfero da cui era partito, al tempo stesso la lingua, la scrittura e il comportamento dei giapponesi si mostravano assolutamente unici e certamente adatti soltanto a quel paese, in ogni caso inaccessibili a quegli uomini che vestivano allo stesso modo e abitavano nello stesso tipo di casa ma dall’altra parte del mondo.
Goffredo Parise, L’eleganza è frigida, Milano, Adelphi, 2008
Un divario che è reso emblematico dal titolo dell’opera, “L’eleganza è frigida“.
Parise fa riferimento al verso del poeta Saitō Ryokuu, dandogli una interpretazione personale: l’eleganza è la raffinatezza e il perfezionismo estetico che si riscontra nella quotidianità giapponese, dalla cura con la quale sono disposti i cibi nel piatto all’amorevole manualità con cui vengono realizzate le gabbie di protezione ai tronchi degli alberelli sui viali di Tokyo.
La freddezza di questa eleganza, di questo artificio, congela però l’esternazione spontanea dei sentimenti, soffocati da maschere e schemi sociali, che lo scrittore riesce tuttavia a scorgere dietro un lieve rossore del volto, gli stranianti silenzi, le espressioni lapidarie e allusive.
Questa “eleganza frigida” ci ricollega all’altra opera in questione, Libro d’ombra.
2. Libro d’ombra
Stavolta lo sguardo sul Giappone è quello di un autorevole autoctono, lo scrittore Jun’ichiro Tanizaki.
Il suo saggio, Libro d’ombra (più correttamente “Elogio dell’ombra”) è del 1933 ma a leggerlo oggi resta ancora incredibilmente attuale.
Nelle sue pagine viene ripreso il già citato verso di Saitō Ryokuu (nell’unica traduzione italiana viene reso come “L’eleganza è fredda”, Parise prese l’aggettivo “frigida” dalla traduzione inglese, “elegance is frigid”), collegandolo a qualcosa di molto più prosaico, il freddo del gabinetto in stile giapponese, che Tanizaki, apprezzando il connubio con la natura, ritiene tutt’altro che volgare:
…un piacere fisiologico [che] solo nel gabinetto alla giapponese, fra lisce pareti di legno dalle sottili venature, mirando l’azzurro del cielo e il verde della vegetazione, si può assaporare fino in fondo. Insisto: sono necessari una lieve penombra, nessuna fulgidezza, la pulizia più accurata, e un silenzio così profondo che sia possibile udire lontano un volo di zanzare. Senza tali requisiti non si dà gabinetto ideale. […] Quanti autori di haiku devono aver trovato, alla latrina, il tema dei loro versi! Non sembri azzardato affermare che, nella costruzione dei gabinetti, l’architettura giapponese ha toccato il sommo della raffinatezza.
Tanizaki Jun’ichiro, Libro d’ombra, Milano, Bompiani, 2002
Bisogna ricordare che lo scrittore, vissuto a cavallo tra Otto e Novecento, ha assistito agli effetti della prepotente “occidentalizzazione”, con la conseguente trasformazione di un paese feudale e isolato in una superpotenza tecnologica.
Tanizaki rievoca nostalgicamente quei tempi in cui ci si soffermava a gustare le percezioni offerte dalle gradazioni d’ombra: l’uso della luce elettrica, importata in modo massiccio ed esasperato, ha dissolto quelle sensazioni malinconiche che l’oscurità dispensava e su cui ogni oggetto e ambiente giapponese era stato modellato. Citando le sue parole, “Non è nella cosa in sé, ma nei gradi d’ombra, e nei prodotti del chiaroscuro, che risiede la beltà”.
Passando in rassegna ogni aspetto della vita quotidiana giapponese, dalle stoviglie, al tokonoma (piccola nicchia costruita all’interno della stanza), dalle pietanze tradizionali al tetto degli edifici, tutto sembra essere stato concepito per ricreare una flebile varietà di ombreggiature che il sensibile animo giapponese ha imparato per tradizione ad apprezzare e a trarne piacere.
Stanze, già di per sé poco chiare, noi cerchiamo di renderle ancora più fosche, dilatando lo spazio sotto le gronde, o frapponendo talvolta, fra il buio interno e le naturali chiarità atmosferiche, lo schermo di una veranda. Del sole fulgente che brilla sul nostro giardino non ci raggiunge che uno spento riflesso, filtrato attraverso la carta opalescente dello shōji. Questa luce mitigata e indiretta è l’elemento più importante della casa giapponese. Perché quietamente e silenziosamente penetri, lei così debole, ed estenuata, e melanconica, nella nostra casa, rivestiamo i muri con intonaci di colore neutro. […] È incantevole la luce incerta e delicata che entra e indugia nelle nostre stanze, simile all’ultimo bagliore del tramonto! Questo riverbero, o piuttosto scurimento, supera per me ogni altra decorazione: mai mi stancherò di contemplarlo.
Tanizaki Jun’ichiro, Libro d’ombra, Milano, Bompiani, 2002, pp. 41-2
V’è, forse, in noi Orientali, un’inclinazione ad accettare i limiti, e le circostanze, della vita. Ci rassegniamo all’ombra, così com’è, e senza repulsione. La luce è fievole? Lasciamo che le tenebre ci inghiottano, e scopriamo loro una beltà. Al contrario, l’Occidentale crede nel progresso, e vuol mutare di stato. È passato dalla candela al petrolio, dal petrolio al gas, dal gas all’elettricità, inseguendo una chiarità che snidasse sin l’ultima particella d’ombra.
Tanizaki Jun’ichiro, Libro d’ombra, Milano, Bompiani, 2002, p.68
Perché quindi “ci rassegniamo ad abbandonare tutti i nostri usi? Perché rinunciamo ai nostri gusti? Perché non tentiamo di conciliare il nuovo con la nostra sensibilità?”, si chiede Tanizaki. A distanza di ottant’anni dalla pubblicazione dell’opera, il Giappone se lo sta ancora chiedendo. O forse no. Forse, “l’uso smodato della luce elettrica lo ha ormai intossicato”.
I libri