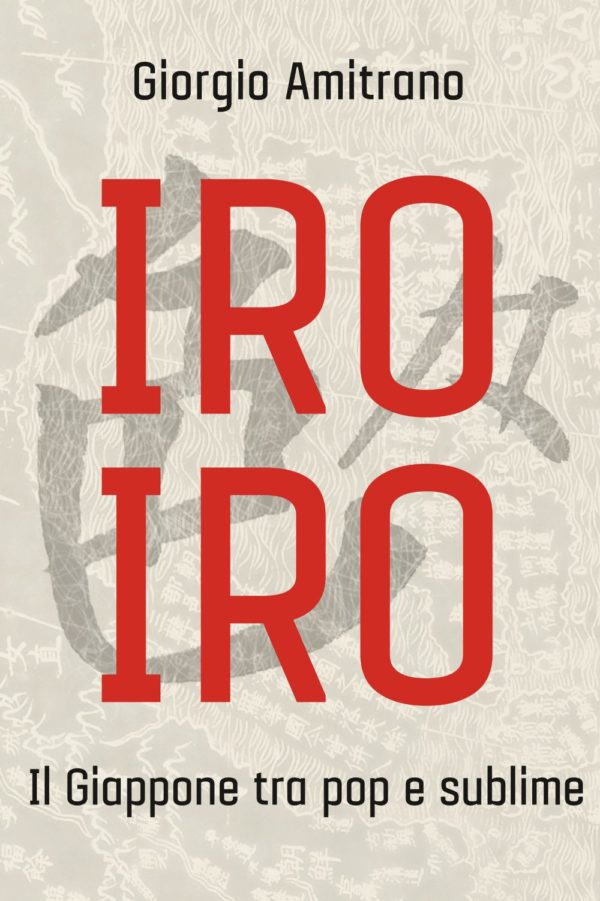Parto sempre molto prevenuta ogni volta che sfoglio un nuovo libro dedicato al Giappone, forse a causa della pubblicazione compulsiva negli ultimi anni di testi approssimativi dedicati al paese del Sol Levante, dai metodi miracolosi per raggiungere la felicità alle banalizzazioni della cultura pop nipponica.
Solo che in questo caso a scrivere è Giorgio Amitrano, uno dei più importanti yamatologi (o nipponisti, che dir si voglia, io preferisco il primo) italiani e al tempo stesso un traduttore di una raffinatezza unica: è grazie alla sua traduzione che Banana Yoshimoto ha acquistato fama fuori dal Giappone. Kitchen fu infatti tradotto per la prima volta in assoluto nel 1991 in Italia. Appunto da Amitrano che, c’è da scommetterci, ha contribuito non poco al successo mondiale della scrittrice.
Quella di Amitrano è una scrittura che rispecchia un po’ il concetto di shibumi 渋み, la sensibilità giapponese per l’eleganza disadorna. Con grande erudizione e gusto tratta non solo della cultura tradizionale del Giappone, ma anche del pop e delle forme d’arte contemporanea, aspetti spesso disdegnati dall’imbolsito ambiente accademico. È un dialogo tra le parti, con intriganti salti cronologici dal medioevo al presente, dal bandito feroce dell’epoca Heian ai film horror di Miike Takeshi. Non manca di evidenziare la capacità della cultura giapponese di spostarsi con disinvoltura in ogni ambito dall’alto al basso, dal solenne al giocoso, da riflessioni filosofiche a commenti frivoli, che siano i testi dei grandi autori classici, come Sei Shōnagon e Kenkō, o gli anime di Hayao Miyazaki. Dal pop al sublime, come recita il sottotitolo.
Il pop ha restituito al Giappone l’armonia tra serietà e leggerezza che era stata sempre una sua dote preziosa.
Il pop con le sue svariate forme, a partire da anime, manga e videogiochi, ma anche l’estetica kawaii di Hello Kitty e il karaoke, è una delle forme di soft power che ha permesso al Giappone di essere conosciuto e amato a migliaia di chilometri di distanza, ben prima che molti di noi potessero effettivamente metterci piede.
A un tratto è apparso evidente che il Giappone aveva invaso il nostro mondo, esercitando un’influenza pervasiva in diversi ambiti, a cominciare da quello estetico. La sua sensibilità si è insinuata nella nostra, arricchendola di sfumature nuove e diverse.

Varie cose, come luoghi e colori
“Iro iro” 色々 in giapponese significa “varie cose”. Il libro è infatti una riflessione che abbraccia vari aspetti della cultura giapponese: la scrittura, la cerimonia, la felicità, la realtà e l’irrealtà, le stagioni, il karaoke, la bellezza. Ma preso da solo, “Iro” 色 vuol dire colore. E questo libro sembra tingersi pagina dopo pagina dei colori del Giappone, spesso associati a luoghi specifici. Luoghi che sono spunti per l’autore per rievocare il vissuto e abbracciare un’ampia gamme di tematiche, tutte connesse e pertinenti.
Dal bianco al rosso, al variare di stagione
Le stagioni, per esempio, sono celebrate nella vita quotidiana e nella letteratura sin dai tempi antichissimi in raccolte poetiche come il Kokinwakashū e si manifestano in un incontenibile tripudio di colori.
D’inverno, il bianco della neve riveste le vette più elevate e come un manto si stende su intere regioni come lo Hokkaidō. Forse non tutti sanno che “neve” in giapponese si può tradurre con oltre cento parole che descrivono tipologie di neve diversa, in base alla consistenza o alle gradazioni di colore. La neve è inoltre un elemento paesaggistico importante in molti romanzi, da Il paese delle nevi di Yasunari Kawabata a Dance Dance Dance di Murakami, ambientato in una Sapporo imbiancata.

La neve è uno scenario prediletto anche del grande scrittore Kenji Miyazawa, originario di Hanamaki, nella settentrionale provincia di Iwate. Amitrano visita il Rinpūsha, il negozio e sala da tè dedicati allo scrittore, gestito dal nipote del fratello minore. Oltre a raccontare l’episodio, Amitrano ci fa conoscere meglio la figura di questo scrittore poliedrico e spirituale con riflessioni e citazioni dalle sue opere.
A Hanamaki, aggiungo io, oggi c’è anche il Miyazawa Kenji Memorial Museum e l’adiacente Yamaneko-ken, un ristorante costruito ispirandosi alla popolare storia per ragazzi di Kenji Miyazawa Un ristorante pieno di richieste (Chūmon no ōi ryōriten).

Poi arriva la primavera e l’atmosfera si arricchisce di sfumature rosacee: numerose gradazioni dal bianco al rosa confetto tingono i petali dei ciliegi che fioriscono gradualmente, da sud a nord. Come molti sapranno, in Giappone c’è proprio una sorta di meteo che annuncia la progressiva fioritura di questi alberi per poter organizzare quello splendido rito che è l’hanami 花見: l’ammirazione dei ciliegi in fiore, un’usanza spesso conviviale che vede molte persone ritrovarsi a celebrare la bellezza della natura stendendo pittoreschi teli blu sotto le chiome fiorite, con abbondante sakè e qualche conseguente sbronza. E non senza una nota di malinconia, perché il fiore di ciliegio è l’emblema del wabi-sabi 侘び寂び, la bellezza effimera e malinconica delle cose.
Uno spettacolo che a Tokyo si può ammirare passeggiando lungo il Chidorigafuchi, fossato che cinge il palazzo imperiale e che passa davanti all’Istituto Italiano di Cultura, di cui Amitrano è stato direttore.

E dal rosso laccato dell’edificio progettato da Gae Aulenti per ospitare l’Istituto Italiano di Cultura si passa al rosso fuoco delle foglie di acero in autunno. Il momiji 紅葉, ossia l’accendersi di tonalità intense del fogliame degli aceri, è un celebre spettacolo che la natura ci offre al Kiyomizudera, a Kyoto, un tempio affacciato su una vallata alberata che d’autunno desta una suggestione indescrivibile. Ma il momiji si ammira in innumerevoli altri luoghi: l’autore consiglia il Saihōji, detto anche Kokedera (famoso anche per i muschi), oppure Arashiyama, entrambi a Kyoto. Ce ne sono molti sparsi per tutto il Giappone: a me vengono in mente le bellissime tonalità del Rikugien a Tokyo che durante la stagione autunnale è aperto anche di notte e illuminato da luci delicate.

Il verde e il nero
Dal rosso si passa al suo complementare, il verde, quello vivace della polvere di tè matcha utilizzata per le cerimonie cha no yu (anche chadō o sadō 茶道, ovvero “via del tè”). L’autore ci descrive l’emozione e la pacatezza di questa liturgia che si tramanda da secoli, spendendo qualche parola anche sulla predilezione dei giapponesi per i rituali stabiliti, retaggio di una società confuciana che aiuta gli individui a conformarsi al loro ruolo e a non disturbare l’ordine sociale. Liturgie spesso svuotate di senso e portate alle estreme conseguenze, “in cui l’umanità è sacrificata in favore di qualcosa di astratto, di un feticcio senza significato”, come viene esemplarmente descritto nel film La cerimonia (Gishiki, 1971) di Nagisa Ōshima, dove le nozze sono celebrate anche in assenza della sposa, perché “l’osservanza delle forme è più importante della sostanza e della dignità delle persone”.

Quindi si tocca l’epoca degli Stati Combattenti (sengoku jidai) con la storia di Sen no Rikyū, raffinatissimo e audace maestro di cerimonia del tè, e dal verde si passa al nero con un’altra sorta di cerimonia odierna, quella del caffè, che ha il suo tempio nei kissaten in stile occidentale. Anche nel somministrare le varie coniugazioni di caffè, i giapponesi hanno applicato la ricerca per la perfezione, il kodawari 拘り, ossia l’atteggiamento perfezionista e meticoloso diffuso profondamente nella cultura. L’interesse maniacale per lo studio del caffè si assapora in diversi locali che di questa bevanda hanno fatto un culto: l’autore menziona per esperienza personale il Jikabaisen Kōhī Bon, a due passi dalla stazione JR Shinjuku a Tokyo, e il caffè Marufuku, a Osaka, fondato nel 1934 in uno stile che ricrea una versione romanticizzata dell’Europa.

Poi piano piano i kissaten hanno perso interesse per la preparazione certosina della bevanda, e hanno oltrepassato le frontiere del concetto di caffetteria trasformandosi in Maid Cafè e Neko Cafè (questi ultimi arrivati anche in Italia, aggiungo io, come il Crazy Cat Cafè di Milano), ma qui si ritorna al tema del pop, confermando ancora una volta la felice e costante compresenza in Giappone di nobile e popolare.
La felicità e lo splendore dell’oro
Se dico “oro” e “Giappone” molti di voi penseranno al kintsugi 金継ぎ, l’arte di riparare oggetti di ceramica con l’oro così da lasciare le giunture visibili e valorizzare metaforicamente le ferite, anche quelle dell’essere umano. Concetti come questo, così come quello dell’ikigai (poco diffuso in Giappone e traducibile in “ragione di vivere”), oltre alle pubblicazioni sulla magica arte del riordino o sulle gioie del minimalismo, hanno contribuito “a diffondere l’illusione che il Giappone possieda chiavi di benessere e felicità”.
Al turista che arriva nel Sol Levante un paese così sicuro, ordinato e funzionale può trasmettere un’idea di quiete e felicità. Attenzione però, ci dice Amitrano: non confondiamo la felicità “con la soddisfazione che deriva da una organizzazione efficiente della vita sociale”. Il Giappone è anche quel paese dagli inquietanti problemi sociali, dell’alta percentuale di suicidi, di fenomeni come il karōshi, la morte da troppo lavoro, e gli hikikomori, i giovani che vivono da reclusi in casa.
Capire cosa significhi “felicità” nel Giappone contemporaneo è complicato, ma sicuramente assume una sua forma nelle parole di Banana Yoshimoto, quando nei suoi romanzi ce la descrive “non come condizione di beatitudine permanente, piuttosto come uno stato di gioia che si manifesta per istanti brevi ma luminosi”.
Tornando quindi un passo indietro, se dico “oro” e “Giappone” potreste d’ora in poi farvi venire in mente un’altra cosa, una delle piccole gemme di Kyoto, ahimè presa d’assalto dai turisti: il Kinkakuji, (il Padiglione d’Oro), che fu la residenza dello shōgun Ashikaga Yoshimitsu, grande mecenate delle arti, colui che incoraggiò Zeami per lo sviluppo del teatro nō e Sen no Rikyū per l’arte della cerimonia del tè (finché poi non esiliò il primo e costrinse al seppuku il secondo). Il Kinkakuji è anche il grande protagonista del romanzo omonimo di Yukio Mishima, ispirato a un fatto reale. Nel 1950 un giovane monaco appiccò il fuoco alla struttura: sembra che la sofferenza per il suo aspetto sgraziato e la sua imbarazzante balbuzie, lo abbia portato ad essere invidioso della bellezza immortale del tempio, così da averne causato la fine in un impeto di vendetta e onnipotenza.

Ci sarebbe ancora tanto da dire, ma questa non è né un’analisi critica, né un bignami del libro di Amitrano; è un semplice suggerimento di lettura.
Si tratta di un libro scritto sulla base dell’esperienza dell’autore, ma non è un diario di viaggio; rievoca memorie personali, ma non indugia nel solipsismo: anzi, gli episodi accaduti sono funzionali a descrivere una cultura con le sue luci e ombre, grazie anche alla capacità dell’autore di comunicare lo stupore fatto di piccole sensazioni, pacate e quasi impercettibili, che suscita costantemente il Giappone.